|
|
Toscano di Grosseto, 67 anni ben portati, autodidatta, non
guida, non possiede il cellulare, non segue i ritmi e le
mode della società consumistica, definisce la sua esistenza
come quella di un “vietnamita che nella boscaglia sopravvive
con un pugno di riso”. In più, ama trascorrere le giornate
nel suo appartamento, vittima della sua “vocazione alla
prigionia”, rinchiuso in una casa che non è solo il suo
studio, ma l’universo-spazio in cui costruisce e modella i
suoi dipinti, con un’attenzione spasmodica per il
“mestiere”, per quella tecnica che considera imprescindibile
per chi voglia definirsi pittore. E pittore intimista
si sente Paolo
 Giorgi,
al punto che quasi tutte le sue opere hanno come
protagoniste sua moglie e sua figlia. Alla sua scarsa
considerazione per l’arte contemporanea unisce l’amore per i
grandi autori del passato, italiani e fiamminghi, con una
particolare predilezione per il senso di meravigliosa e
meravigliata cristallizzazione del tempo contenuto nelle
opere di Jan Vermeer, il grande pittore olandese di cui
Giorgi non fatica a sentirsi “debitore”. Giorgi,
al punto che quasi tutte le sue opere hanno come
protagoniste sua moglie e sua figlia. Alla sua scarsa
considerazione per l’arte contemporanea unisce l’amore per i
grandi autori del passato, italiani e fiamminghi, con una
particolare predilezione per il senso di meravigliosa e
meravigliata cristallizzazione del tempo contenuto nelle
opere di Jan Vermeer, il grande pittore olandese di cui
Giorgi non fatica a sentirsi “debitore”.
Maestro, da cosa nasce la sua critica verso gli artisti
contemporanei?
Innanzitutto io non li critico, li disprezzo. E non voglio
essere confuso con certi eccessi smodati e ridicoli che
siamo costretti spesso a vedere e a subire. Il vero artista,
il vero pittore, vive del suo mercato, quando fortunatamente
per lui ce l’ha, mentre l’arte moderna e contemporanea vive
dell’Erario. È molto difficile trovare nella casa di un
privato un’opera di un autore di oggi, soprattutto italiano,
però se si va in un museo, ad Amsterdam ad esempio, si
incontra, accanto alle opere di Van Gogh, quelle di qualche
“grande eroe nostrano”, una presenza figlia della rete di
rapporti, del “giro” esistente tra direttori di musei. La
famosa “gente”, nella quale comprendo anche quella
provveduta, che frequenta chilometri e chilometri di
“macerie” alla Biennale di Venezia o alla
Documenta di Kassel, lo fa per dire: “Ci sono stato”. Ma
sono soltanto chilometri di noia insopportabile.
Proprio nessun autore contemporaneo l’ha mai interessata?
Soltanto Francis Bacon e Lucian Freud hanno suscitato la mia
attenzione, ma sono stati degli amori intellettuali, le mie
passioni finiscono con la grande classicità.

Dei
maestri del passato mi ha spesso colpito la tecnica con cui
lavoravano, perché, amando io soprattutto il “mestiere”,
penso che sia importante per un artista saper disegnare
bene. Se poi a questo si aggiunge anche la genialità, allora
meglio ancora. Ed è grazie a questo mio “mestiere” che ho
potuto fare tanti ritratti, lavorare tanto intensamente su
committenza, come per le “Quattro stagioni”, recentemente
commissionatemi da Paolo Bulgari ed esposte nel febbraio
dello scorso anno presso la sede romana della Banca Esperia.
Non
vede un futuro roseo per chi vuole dipingere, allora?
Tenere
un pennello in mano è considerato un vero e proprio delitto.
Oggi i grandi quotidiani quasi mai recensiscono un pittore,
ma soltanto autori che, nella loro massima espressione,
posso considerare dei passabili scenografi. Ormai i media
hanno sposato questa causa, la visibilità è tutto e quindi
poco resta da fare. Almeno per me, essere fuori da questo
“correntone”, da questa orgia stupida e becera, può essere
addirittura lusinghiero. Se in più aggiungiamo che sono una
persona, in senso filosofico, assolutamente inattuale -
visto che non guido, non ho il telefonino - di essere fuori
da tutto questo sono ben contento. Insieme a mia moglie –
anche lei non guida – ci sentiamo un po’ come dei
“vietnamiti” nella boscaglia: finché c’è il riso, campiamo.
Lei
sta forse dicendo che la pittura è destinata a scomparire
nel nostro Paese?
Assolutamente no. Anzi, l’Italia, e aggiungerei anche la
Spagna, sono due isole felici, per quanto riguarda il numero
di talenti pittorici a disposizione. Con il grave limite
però che questi stessi talenti in alcuni casi sono molto
molto “sotterranei” perché il crimine maggiore per un
artista oggi, anche in questi due Paesi, è, comunque e
sempre, quello di usare i pennelli.
Da
qui ne discende in maniera naturale la sua ricerca di
modelli di riferimento nel passato e in Jan Vermeer in
particolare. Cosa l’ha colpita del grande maestro di Delft?
Innanzitutto il fatto di essere stato un grande intimista
che dipingeva, all’interno di casa sua, figure femminili che
pare fossero la moglie e le figlie. Da parte mia ho quasi
sempre dipinto solo mia figlia e mia moglie e poi gli
interni della casa in cui vivo: librerie, mobili, tappeti.
Mi sento quindi anche io un pittore intimista, in questo
aiutato da quella che sono solito definire la mia vocazione
alla prigionia all’interno della mia casa.
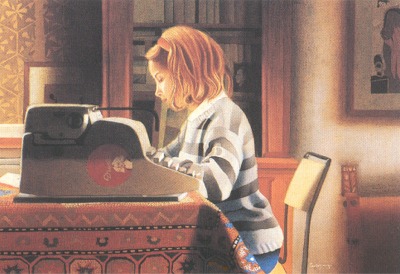
Parliamo ora un po’ della sua vita. Ha saputo fin da piccolo
che un giorno sarebbe divenuto un pittore?
No,
direi di no.
L’incontro si è realizzato in maniera molto romantica e
inattuale. Io sono un orfano precocissimo che non ha potuto
evitare il servizio militare. In quel periodo mi sono
ammalato di tubercolosi, una patologia elettiva, visto che a
metà Ottocento è stata a lungo considerata la malattia degli
artisti. Venni inviato in una casa di cura ai confini con la
Svizzera. E qui sentii questa forte attrazione che mi portò
a ottime letture come “La montagna incantata” di Thomas
Mann. D’altra parte lì di tempo ne avevamo parecchio a
disposizione, stava a ciascuno di noi decidere se perderlo o
utilizzarlo. Chi sceglieva questa seconda ipotesi poteva
dedicarsi a varie attività: io un giorno, scendendo a valle,
acquistai delle tele e un po’ di colori. Ho iniziato così,
senza mai fare una scuola o un’accademia e, malgrado il mio
molto lavorare e poco produrre, la mia assoluta assenza di
compromessi seri e il mio pessimo carattere, sono riuscito a
costruirmi una mia “piccola fortuna” in campo pittorico. Ciò
è potuto accadere anche grazie al fatto che ho una certa
stima di me stesso e non vendo fumo. Per questo ho sempre
cercato di lavorare fuori dalla “canizza”, anche se poi le
mie opere sono presenti in alcuni luoghi importanti come la
collezione della Farnesina e ho avuto tre inviti alla
Quadriennale. Non mi lamento quindi della mia personale
sommatoria carattere-attività. Tornando alla “Montagna
incantata”, sull’opera di Mann ho fatto un ciclo di dipinti
molto grandi che ha costituito il momento di svolta della
mia carriera artistica, attirandomi per la prima volta
l’attenzione della critica più provveduta al mio lavoro.
Quei grandi quadri che ho dipinto in omaggio a quel grande
libro sono stati l’inizio di quella che ho già definito la
“piccola fortuna”.

Mi
sembra di capire che da subito a iniziato a dipingere.
No,
assolutamente no. Mi sono immediatamente accorto di quanto
fosse difficile lavorare su una tela, ho ben presto quindi
lasciato pennelli e tavolozza e mi sono messo a disegnare,
soprattutto i grandi maestri del passato, come Raffaello,
David. Questo per molti anni, in una sorta di apprendistato
che mi ha portato poi al mio primo quadro, commissionato da
un grande albergo toscano, nel 1971, e ispirato, come farò
poi sempre nel corso della mia vita artistica, da uno dei
miei grandi amori, Jan Vermeer e dal suo “Pittore
nell’atelier”. In questa opera io ritraggo me stesso che
ritrae se stesso che ritrae se stesso, e colloco uno dei
miei primi tappeti, dando il via a una consuetudine, quella
appunto di dipingere tappeti, che mi ha accompagnato negli
anni.
Perché
a un certo punto della sua vita ha scelto di trasferirsi
nella capitale?
L’ho
fatto nella seconda metà degli anni Settanta quando mi sono
accorto che per dipingere la provincia mi andava stretta. I
primi anni sono stati orrendi, come quel giorno in cui uscì
per la prima volta il quotidiano “la Repubblica” e dovetti
scegliere se comprarlo al posto di un rosso di cadmio o di
un panino, al costo di cinquecento lire. Queste ristrettezze
erano dovute anche al fatto che pagavo l’affitto per una
piccola casa, molto carina, in via dei Coronari che ho poi
abbandonato nell’84 quando è nata mia figlia per trasferirmi
qui, nei pressi di viale Liegi, dove ora vivo e ho il mio
studio.
Cosa
le ha dato Roma?
Un grande
cambiamento, almeno in una persona come me che ama stare in
casa: col tempo ho iniziato a guardarmi intorno, a osservare
questa città, cosa che non avevo fatto prima, e a dipingere
qualche quadro su Roma. Improvvisamente, questa “cosa” che
mi ospitava non mi era più estranea, non era più soltanto
un’entità pragmatica e tumultuosa, forse per la prima volta
la sentivo casa mia.
Resta
legato alle sue origini?
Sì, ma
preferisco essere cittadino del mondo, pur riconoscendo le
vette artistiche insuperabili di città come Firenze e Siena,
o i “Grandissimi” lì nati. Due anni fa ebbi un amore
turbinoso per il Ghirlandaio che ho scoperto all’improvviso,
dopo una lettura casuale. Poi è passato.
L’essere toscano ha influito sulla sua arte?
Penso di
sì perché c’è molta “terra di Siena” nel mio lavoro, c’è la
maniera leonardesca di usare le velature. In più, per me che
sono un patito del “mestiere”, la buona tecnica nasce tra
la Fiandre e la Toscana. Se fu infatti Jacopo de’ Barbari a
portare la pittura ad olio in Italia, sono stati poi i
toscani, basti pensare al Michelangelo del “Tondo Doni” e a
Sandro Botticelli, che hanno elevato, quello che mi piace
definire il “mestiere”, ad altissimi livelli. Oltre a essere
dei geni, sapevano fare tutto, un mazzo di fiori come un
ritratto o un mare in tempesta.
Cosa deve accadere perché Paolo Giorgi si metta davanti al
cavalletto e dipinga?
Sono
un artigiano indefesso, non ho ispirazione, sono uno che
lavora costantemente, ma affrontando grandi difficoltà
tecniche, per cui produco poco. Gli scatti di interesse ci
sono, ma sono molto rari, in compenso ci sono quadri che
stanno lì, non finiti e da cui aspetto “un segnale” per
riprendere a lavorarci.
Che
rapporti instaura con le sue opere?
È un
grande agone, ma non sono delle nemiche.
Quando se ne separa, soffre?
No,
no, assolutamente. Anzi, è la mia più grande felicità.
Secondo me, nel 2007, un pittore è tale se vende i suoi
quadri. Studiando le lettere di Van Gogh al fratello Theo,
mi sono reso conto di quanto deve essere stato per lui
terribile e angoscioso non riuscire a vendere i suoi quadri
pur avendo un fratello che era un grandissimo gallerista.
D’altra parte Van Gogh è soltanto nei nove anni finali della
sua vita che diventa quello che conosciamo, bruciando in
così poco tempo tutta la sua vena artistica. Come Gauguin
che, se non fosse andato a Tahiti, sarebbe rimasto un
pittore come tanti altri. L’esotismo carnale che scopre lì,
invece, quell’altrove fantastico che dipinge con i
suoi totem in Polinesia, tutto ciò rappresenta uno scatto,
non solo nel suo esotismo, ma anche formale, tale da
trasformarlo in un pittore che disprezza la forma per
raggiungere l’arcano che sente nei suoi segni. E così
Van Gogh, negli ultimi nove anni, al sole della Provenza,
arroventa tutto con il suo segno psicotico, mentre
fintantoché si cimenta nel tentativo della “buona pittura”,
che peraltro non sa fare, resta un pittore modestissimo,
buio, fosco, torvo.
A
proposito di buio, quanto è importante la luce nelle sue
opere?
Anche
se artificiale - in fondo io lavoro in un bunker - la luce è
fondamentale. Ogni volta mi auguro che un’aura psichica
risolva le mie opere, altrimenti sarebbero delle banalità. E
ripenso alle bottiglie di Morandi, in cui quello che dà loro
un senso è lo sguardo che le colloca in un’aura temporale,
peraltro non esistente, grazie non soltanto al segno
dell’autore, ma anche alla sua luce.
Quanta
emozione e quanta ragione sono presenti nelle sue opere?

La
ragione è importante, soprattutto nella gestione della vita
di un pittore che, secondo me, può essere paragonata a
quella di un calciatore che se si allena, fa nella giornata
le sue corse, i suoi scatti, il suo lavoro in palestra, sta
a dieta, frequenta le donne con parsimonia, è già a un buon
punto; se poi su queste basi si innesta il genio, allora
abbiamo il campione, altrimenti si parla del Ronaldo di
oggi, dieci chili in soprappeso e fine dei giochi. Per un
pittore – e non parlo di chi mette la nonna su una sedia e
le fa fotografie, attorciglia le rotaie del tram, o si
appende agli alberi - è la stessa cosa: va a letto presto la
sera, non beve e non fa uso di droghe, altrimenti il
risultato è modesto.
Dipinge direttamente sulla tela le sue opere?
Assolutamente no, le preparo con grande cura e grande
attenzione. Prima disegno, poi ricalco oppure ingrandisco
con una tecnica di sviluppo a quadratini molto antica.
Quali
sono gli elementi costitutivi della sua pittura?
In primis
la perizia tecnica, la mia tensione morale è verso la
perizia tecnica, dopo ben venga la genialità, se c’é.
La
famiglia mi sembra rappresentare un elemento fondamentale
nell’arte di Paolo Giorgi.
Sì, e non
solo perché appare nella stragrande maggioranza delle mie
opere. Anche spiritualmente la presenza di mia moglie e di
mia figlia influiscono sui miei quadri.
Che
tipo di rapporto ha con l’amicizia?
Scomodo.
Essendo io una persona molto fedele, mi trovo male in un
mondo dove si va sempre più verso un’ottica di utilitarismo
sfrenato: se le persone hanno una necessità si fanno in
quattro, superato quel momento….Io poi sono un inurbato,
come peraltro mia moglie, toscana anche lei, e non abbiamo
qui parenti. Tutte le nostre conoscenze sono relativamente
recenti, mentre negli anni mi sono reso conto che le grandi
amicizie della vita si radicano in una stagione
dell’esistenza molto precoce. Quindi, se si vive sempre
nello stesso posto, si hanno maggiori possibilità di avere e
conservare amicizie. Io ho qualche amico in Toscana, la
terra dove sono nato, qui a Roma ho tante conoscenze, ma
amici…..pochi.
Oltre alla pittura, si è dedicato a qualche altra forma di arte?
Agli
acquarelli. Da poco ho finito una serie di acquarelli per il
150° anniversario della nascita di Puccini, un evento
importante per un accanito melomane quale io sono,
appassionato in particolare del Mozart “italiano” delle
“Nozze di Figaro”, “Così fan tutte”, “Don Giovanni”, “Idomeneo”,
e di Richard Wagner. Mi dedico molto agli acquarelli senza
considerarli un genere di “serie B” e anche in questo campo
detesto lo schizzo, l’effettaccio, opero con gli acquarelli
con la stessa attenzione che dedico alla pittura.
Qual è il suo rapporto con l’Eros?
É una
cosa che mi interessa furor di misura, moltissimo e in tutte
le componenti. Ha avuto sempre una preponderanza spudorata
in tutta la mia vita.
E
il Sacro?
Lo
incontro in una zona recondita, arcana, della natura, che
non ha nulla a che vedere con il credo religioso, mentre
invece sempre più si risolve nello stupore dell’accadimento
naturale.
A
quando la prossima mostra di Paolo Giorgi?
Allo
stato attuale non ho in previsione nulla, visto che nel 2007
ho fatto ben due esposizioni a Roma, una all’interno della
sede della Banca Esperia a Piazza di Spagna, e una alla “Ca’
d’Oro” in maggio per la “Primaverile dell’Argam”,
l’associazione delle gallerie romane. In questa occasione
ogni galleria invita ad esporre un autore di qualità. E io
sono stato chiamato da Porcella, proprietario della “Ca’
d’Oro”, con un po’ di miei quadri.
Esiste un sogno che ancora non ha realizzato?
Sono
tanti, troppi, e crescono con il crescere dell’età.
|
|





