|
Si corre
un solo rischio, visitando il Museo di Piana delle Orme,
pochi chilometri a sud di Latina*: quello di perdere la
nozione del tempo, rapiti dalle emozioni, dallo stupore di
scoprire oggetti, suoni, addirittura odori, della nostra
infanzia, delle nostre tradizioni, del “come eravamo”, della
Storia del ‘900 di questo Paese. E tutto per merito della
passione genuina, per qualche aspetto fanciullesca, di
Mariano De Pasquale, un uomo semplice, che ha dedicato tutta
la sua vita, purtroppo stroncata da una malattia lo scorso
settembre a soli 68 anni, al lavoro e al collezionismo.

“Raccoglieva ogni oggetto che potesse raccontare la Storia –
spiega Alda Dalzini – direttrice del Museo e fidata
collaboratrice di De Pasquale fin dal 1991 – e così
collezionava ricordi”. Figlio di allevatori trasformatisi
poi in agricoltori, originario della provincia di Messina,
De Pasquale si trasferì nella zona di Latina, a Borgo
Sabotino, con tutta la sua famiglia alla fine degli anni
’50. Qui conobbe la realtà della bonifica pontina e se ne
appassionò. Iniziata nel 1962 con una vecchia jeep data in
pagamento per una partita di fiori (nel frattempo era
divenuto floricoltore), ben presto la sua collezione di
oggetti - tutti, seguendo la sua regola-prima, restaurati e
funzionanti – raggiunse la ragguardevole cifra di 50 mila
reperti. “È a questo punto che scatta la grande intuizione
di De Pasquale – continua nel suo racconto Alda Dalzini –
per dare un senso a tutta la sua collezione: costruire un
grande museo in cui netto fosse il rifiuto della guerra,
dove il visitatore potesse vedere cosa provoca, cosa è un
conflitto”. E lo spunto gli venne da un ricordo: quello del
padre che lacero e amareggiato, rientra a casa dopo cinque
anni di guerra, poggia lo zaino a terra e pronuncia poche,
ma nette parole: “Che la guerra ora se la facciano loro!!”.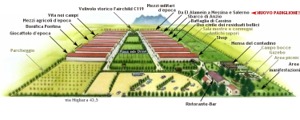
Per fare
ciò, De Pasquale rileva un’azienda avicola adiacente alla
sua ditta di produzione floreale, vi impianta una struttura
agrituristica e inizia a costruirci il suo museo, inaugurato
il 29 novembre 1997. “Tutto fu fatto con molta fretta –
ricorda la direttrice – come peraltro in ogni altra cosa
della sua esistenza. Era come se avesse un
presentimento…….”.
Così è
nata la struttura museale di Piana delle Orme, con oltre 25
mila metri quadrati espositivi suddivisi in 11 padiglioni
tematici, tutti sempre fruibili dai visitatori (chiusura
soltanto nel giorno di Natale) con orari molto flessibili,
servizi di accoglienza, un ristorante e una mensa
self-service, guide formate dallo stesso museo e ampi spazi
di verde con aree attrezzate per i pic-nic. Senza
dimenticare la funzione didattica della struttura. “Tutti i
pezzi all’interno dei padiglioni – spiega la direttrice –
sono inseriti in diorami (scenografie, ndr) che fanno
rivivere la storia. Vogliono essere strumenti di conoscenza
e di memoria per i molti ragazzi che vengono qui in visita,
in un museo che non raccoglie cose morte, ma piuttosto vuole
essere una chiesa dove si celebra il passato”.
Ma ora è
il momento di iniziare il nostro “viaggio” che prende le sue
mosse dal padiglione dedicato ai Giocattoli d’epoca,
l’unico costituito con pezzi prestati da generosi donatori.
A questo proposito Alda Dalzini conserva il ricordo del
momento in cui arrivarono al museo questi giocattoli, quando
vide De Pasquale prendere alcuni di questi oggetti e
rigirarli tra le sue mani molto grandi e indurite dal
lavoro: “Era spaesato, si trovava davanti a qualcosa che non
aveva mai conosciuto, non avendo praticamente mai giocato da
bambino. E si chiedeva, e mi chiedeva, se fossero veramente
belli, se un bambino li avrebbe apprezzati, lui che bambino
non lo era mai stato”. Un dubbio risolto positivamente, se
per i suoi piccoli ospiti ha poi voluto costruire una città
di fantasia, al cui ingresso domina un grande: “C’era una
volta…. ”. Ma qui non si sentono di casa soltanto i piccoli,
anche gli adulti possono trovarvi qualcosa che li faccia
tornare indietro nel tempo: trenini, automobiline di latta,
autocarri, gru, la stazione di polizia, quella dei pompieri,
la casa delle bambole, e poi, ancora, tanti soldatini e
infine, decine e decine di aerei e navi di ogni epoca
perfettamente riprodotti e in scala. Il sogno di ogni
appassionato di modellismo.
Da qui si
esce per entrare nel secondo padiglione, non senza ammirare
gli splendidi pavoni che danno mostra di sé in uno spazio
recintato.
 E
siamo alla Bonifica delle Paludi Pontine, un’opera
già tentata dal Papato nel corso del ‘600 e del ‘700 e poi
dai Governi dell’Italia risorgimentale, ma seriamente
organizzata e portata a termine soltanto da Mussolini a metà
degli anni ’30. Il percorso inizia con una ricostruzione
grafica della situazione di queste zone prima del ’28, anno
in cui prende il via la grande bonifica. Si passa quindi per
la ricostruzione di una fattoria di “lestraioli”, ovvero gli
abitanti che stagionalmente si insediavano in quell’ambiente
ostile e malarico, con tanto di suoni animali e audio-guide
in più lingue. Poi le grandi opere, con attrezzature e
idrovore all’avanguardia tecnologica per quei tempi. E alla
fine il trattore con cui Mussolini, in una posa da “novello
Romolo” immortalata da una grande foto, volle tracciare il
perimetro di quella che sarebbe divenuta la città di Aprilia.
E siamo così alla fase della colonizzazione delle nuove
terre strappate alle paludi pontine. Fu l’Opera Nazionale
Combattenti a occuparsene convincendo a trasferirsi in
queste zone dal nord Italia (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna,
Lombardia, tutte regioni dove la disoccupazione era molto
forte) circa 3 mila famiglie che qui ottennero
l’assegnazione di un podere ciascuna, con annessa la stalla,
il portico, il fienile, il forno, il pozzo, l’abbeveratoio,
l’aia, il pollaio e il porcile. E
siamo alla Bonifica delle Paludi Pontine, un’opera
già tentata dal Papato nel corso del ‘600 e del ‘700 e poi
dai Governi dell’Italia risorgimentale, ma seriamente
organizzata e portata a termine soltanto da Mussolini a metà
degli anni ’30. Il percorso inizia con una ricostruzione
grafica della situazione di queste zone prima del ’28, anno
in cui prende il via la grande bonifica. Si passa quindi per
la ricostruzione di una fattoria di “lestraioli”, ovvero gli
abitanti che stagionalmente si insediavano in quell’ambiente
ostile e malarico, con tanto di suoni animali e audio-guide
in più lingue. Poi le grandi opere, con attrezzature e
idrovore all’avanguardia tecnologica per quei tempi. E alla
fine il trattore con cui Mussolini, in una posa da “novello
Romolo” immortalata da una grande foto, volle tracciare il
perimetro di quella che sarebbe divenuta la città di Aprilia.
E siamo così alla fase della colonizzazione delle nuove
terre strappate alle paludi pontine. Fu l’Opera Nazionale
Combattenti a occuparsene convincendo a trasferirsi in
queste zone dal nord Italia (Veneto, Friuli, Emilia-Romagna,
Lombardia, tutte regioni dove la disoccupazione era molto
forte) circa 3 mila famiglie che qui ottennero
l’assegnazione di un podere ciascuna, con annessa la stalla,
il portico, il fienile, il forno, il pozzo, l’abbeveratoio,
l’aia, il pollaio e il porcile.
Ma per
lavorare la terra occorrono gli attrezzi adatti e ai
Mezzi agricoli d’epoca è dedicato il terzo padiglione
che riserva ai visitatori alcune “chicche”, dei veri pezzi
d’antiquariato, come un torchio di legno del ‘700, un
antichissimo aratro a chiodo, insieme a una
“spannocchiatrice manuale” e una trebbiatrice degli anni
’50. “Qui il nostro intento – spiega la direttrice – è stato
quello di rappresentare il lungo cammino che l’umanità ha
dovuto percorrere per raggiungere quei risultati di
benessere alimentare, economico e sociale che oggi
appartengono alla nostra società”. Non potevano mancare, a
questo punto, i due padiglioni successivi, dedicati alla
Vita nei campi, per un percorso che dal nord al sud
dell’Italia conduce i visitatori attraverso il mondo della
civiltà contadina del nostro Paese. Dodici le sezioni, con
la prima dedicata al ciclo del vino. Qui enormi botti ci
accolgono in un ambiente tanto perfettamente riprodotto che
anche l’odore nell’aria è quello giusto; segue un’altra
sezione dedicata al ciclo dell’olio con un intero frantoio
funzionante ed enormi giare pronte ad accogliere il
“nettare” prodotto. E poi il ciclo del grano, con una
macina, e quello dell’acqua, con un sistema di sollevamento
da pozzo anche questo ancora funzionante. Seguono
l’alpeggio, con la riproduzione di un torrente che scorre,
la fienagione e il ciclo del latte, con tante “mucche”
virtuali che fanno sentire il visitatore come in una vera e
propria fattoria. Infine, il ciclo dell’industria boschiva
(anche qui gli odori sono quelli veri!) e quello del
carbone, alcuni carretti, un’officina da fabbro. A chiudere,
il tema dell’emigrazione anni ’50 e ’60, quando la nascita
dell’industria italiana nel nord costringe tante famiglie
contadine ad abbandonare le campagne e a spostarsi in città.
Siamo così
giunti a metà del lungo percorso espositivo (per una visita
accurata occorrono circa quattro ore). Uscendo dall’ultimo
capannone della fila di sinistra, si attraversa il lungo
viale di eucaliptus e si riprende questo “viaggio” nel
Novecento italiano. Ma al centro del viale ci attendono due
“protagonisti” della visita: un Fairchild C – 119, detto
anche “Vagone volante”, un aereo da trasporto acquistato dal
museo nel ’98 i cui motori si possono avviare, pagando pochi
euro e spingendo un pulsante, e poi una delle ultime
lomotive – tender a vapore, la FS Gr 835 051, anche questa
funzionante con lo stesso metodo del Fairchild.
A questo
punto la visita cambia il suo orizzonte e, abbandonata la
realtà contadina, ci si ritrova immersi in quella della
guerra, qui descritta in tutta la sua semplice tragicità.
Per primi i Mezzi bellici d’epoca, con semoventi,
autoblindo, anfibi, jeep, autocarri, per lo più di
fabbricazione americana, inglese canadese e italiana. Tra
loro spicca una delle “star” del museo, quel carro-armato
Sherman M4 che molti ricorderanno nelle scene finali de “La
vita è bella”, il film di Roberto Benigni vincitore di
Cannes nel ’98 e di tre Oscar nel ’99, ma che ha partecipato
anche alle riprese de “Il paziente inglese”, vincitore di
ben nove premi Oscar nel ’97 e di “Malena”, film questo con
la bellissima Monica Bellucci come protagonista.
E dopo i
veicoli militari, ecco gli orrori della Seconda Guerra
Mondiale, quando a El Alamein migliaia di giovani vite
andarono perdute in una battaglia che, insieme a quella di
Stalingrado, ha rappresentato uno dei momenti decisivi del
conflitto. Di grande effetto l’allestimento di questo
padiglione intitolato Da El Alamein a Messina e Salerno:
i visitatori vengono accolti dalle immagini dell’annuncio di
Mussolini dell’ingresso dell’Italia in guerra, a cui seguono
la mobilitazione delle forze armate e la partenza dei nostri
soldati per i vari fronti. Così si arriva in Africa
settentrionale, in un avamposto italiano nel deserto libico.
Da qui partirà la nostra prima offensiva, lì transiteranno
le nostre truppe ricacciate indietro dalle esigue, ma meglio
organizzate, divisioni inglesi. E sempre in Libia, a
Tripoli, sbarcheranno le truppe tedesche dell’Afrika Korps
guidate dal mitico Rommel, che qui si costruirà la fama di
“volpe del deserto”. Ma ora tutto si è fatto buio! E
svoltato un angolo…… scoppia una battaglia notturna, con i
lampi delle esplosioni, le raffiche di mitragliatrice e le
urla del combattimento. Un’avvertenza per i visitatori:
questo punto del percorso può cogliere di sorpresa e
spaventare, ma lo spirito di chi ha immaginato questa
scenografia è chiaro: soltanto così, finendo dentro a uno
scontro, seppure virtuale, un individuo può avere un pallido
sentore della paura e dello smarrimento che si provano
durante un combattimento reale.
Ma El
Alamein è stata soltanto l’inizio della fine per le forze
dell’Asse. Alcuni mesi più tardi gli Alleati attaccano in
Sicilia per poi risalire la penisola ed effettuare un nuovo
sbarco sulle coste di Salerno. Dalle feritoie di uno dei
bunker sulla costa campana, perfettamente ricostruito, il
visitatore potrà vedere riprodotto quello che i difensori
scorsero la mattina in cui la flotta alleata si presentò
davanti a Salerno. Chiude questo padiglione un’altra delle
“star” del museo, lo Sherman DD, un carro-armato anfibio
usato per la prima volta in Normandia, recuperato dai
fondali davanti le coste laziali nel 2002 e ora visibile
dopo un lungo restauro. Ne restano soltanto tre al mondo e
quello di Piana delle Orme è l’unico ancora funzionante.
Siamo così
all’evento bellico che in qualche modo ha riguardato più da
vicino la zona in cui oggi sorge il museo: lo Sbarco ad
Anzio. Il 22 gennaio 1944 60 mila uomini su 380 navi si
presentarono davanti alle coste laziali per tentare di
creare una testa di ponte che permettesse di aggirare le
difese tedesche a Cassino e arrivare più facilmente a Roma.
L’inerzia e l’inettitudine del comandante americano, che non
approfittò della sorpresa generata dallo sbarco, permisero
al generale Kesserling, a capo delle forze tedesche in
Italia, di bloccare gli Alleati e rendere vana la loro
mossa. Roma sarà così liberata soltanto il 4 giugno 1944! E
qui troviamo un altro “protagonista” del museo: Skipper”,
alla cui storia è dedicata una sezione di questo padiglione.
Questo caccia americano Curtiss P 40L era finito in mare
davanti al litorale di Latina a causa di un’avaria e il
tenente Michael Mauritz, che lo pilotava, si era salvato a
nuoto. Recuperato nel gennaio del ’98 e completamente
restaurato, a settembre dello stesso anno é stato presentato
al pubblico in una cerimonia a cui ha partecipato anche lo
stesso Mauritz, rintracciato negli Stati Uniti e tornato in
Italia per salutare il suo vecchio “compagno”.
Ma se gli
Alleati erano dovuti ricorrere a uno sbarco sul litorale sud
del Lazio, la causa andava ricercata nella terribile
resistenza opposta dalle forze dell’Asse lungo la linea “Gustav”.
E alla Battaglia di Cassino, uno degli episodi più
cruenti della campagna italiana e per questo definita anche
la “Stalingrado d’Italia”, è dedicato il padiglione
successivo. In questo snodo cruciale della linea difensiva
tedesca, poche truppe riuscirono a tenere immobilizzate le
forze alleate e a far pagare loro un altissimo tributo di
sangue. Lungo il percorso si possono così vedere riprodotti
in diorami a grandezza naturale una colonna impantanata nel
fango, una trincea, un accampamento di fortuna, un ospedale
e una stazione radio da campo. Nella parte finale del
percorso il visitatore si trova a calpestare le rovine
dell’Abbazia di Montecassino in una visione impressionante
degli effetti del bombardamento alleato del 15 febbraio
1944. Una serie di immagini dell’entrata del generale Clark
nel giugno del ’44 a Roma segna la conclusione di questa
seconda sezione del museo dedicata agli eventi bellici della
Seconda Guerra Mondiale.
Bisognerà
però attendere la fine di aprile del ‘45 perché il più
grande massacro perpetrato dall’umanità si concluda in
Italia e in Europa. Lasciando un Paese devastato, privo di
tutto, inclusi i mezzi meccanici necessari per far ripartire
agricoltura e industria. È a questo punto che la necessità,
aguzzando l’ingegno, impose l’Uso civile dei residuati
bellici. Nella prima sezione di quest’ultimo padiglione
sono esposti alcuni esempi di quei mezzi riadattati a uso
agricolo o civile, mentre il resto dello spazio è occupato
da un gran numero di mezzi militari di diversa nazionalità,
alcuni costruiti anche dopo la guerra.
E così
siamo giunti alla fine di un “viaggio” che ci ha fatto
rivivere alcuni tra i momenti più importanti della Storia
italiana del ‘900. Un percorso lungo e faticoso, fatto di
immagini di sofferenza, ma anche di esempi di grande dignità
e coraggio offerti dal popolo italiano. Si esce stanchi
dalla visita a Piana delle Orme, ma con la certezza di aver
toccato con mano la realizzazione di un sogno meraviglioso:
il sogno di Mariano De Pasquale.
* Via
Migliara 43,5 – 04010 Borgo Faiti (LT).
Orario
estivo: feriali e festivi dalle 9,00 alle 18,00.
Orario
invernale: feriali dalle 9,00 alle 16,00, festivi dalle 9,00
alle 17,00.
Ingresso:
intero 10,00 euro, ridotto 8,00 euro.
Per
informazioni e prenotazioni: tel.: 0773/258708.
Sito
internet:
www.pianadelleorme.it;
e.mail:
info@pianadelleorme
|
|





