|
Cavalli che volano,
donne che sfidano le leggi della gravità e angeli
infuocati che precipitano a terra. Tutto l’universo
circense del grande maestro russo - in circa 180
opere tra dipinti, gouaches, disegni, sculture e
incisioni - è dal 9 marzo scorso riunito per la
mostra Chagall delle meraviglie* nelle sale
recentemente ristrutturate del Vittoriano di Roma.
È uno spazio della
fantasia quello di fronte al quale si trova il
visitatore, un mondo che il titolo dato all’evento
coglie alla perfezione prendendo a prestito una
frase di Louis Argon, teorico del Dadaismo e del
Surrealismo che per descrivere la lieve e
fantasmagorica ispirazione di Chagall, non trovò di
meglio che paragonarla al “Sogno di una notte di
mezza estate” di Shakespeare. Un mondo di sogno,
dunque, quello del grande maestro di Vitebsk, la cui
“leggerezza” non deve però ingannare: dietro una
patina di apparente ingenuità, l’osservatore attento
può cogliere una complessa articolazione di
esperienze e scelte culturali che va dalle
Avanguardie dei primi anni del Novecento alle più
evolute correnti artistiche contemporanee. Perché
Chagall tutto vide e comprese nel corso della sua
lunga esistenza (1887 – 1985), ma a nessun movimento
diede mai la sua adesione, sempre fedele al tratto
fiabesco della sua poetica interiore, al legame
forte con la tradizione ebraica e con le radici
profonde che affondavano nella sua anima russa.
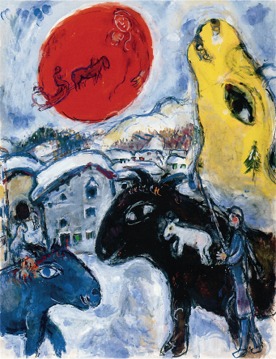
Perché “la sua è
l’arte della favola eterna” ha ricordato Claudio
Strinati, Soprintendente al Polo museale romano nel
corso della conferenza stampa di presentazione,
quell’arte stralunata per la cui ispirazione Chagall
aveva ampiamente attinto al mondo delle vignette
popolari della sua terra, quelle lubok
diffuse tra i ceti popolari russi dell’Ottocento, in
cui la realtà era rappresentata da animali parlanti,
personaggi volanti e galli cavalcati da prodi
cavalieri. Le stesse atmosfere di molte sue opere.
Fantasia dunque, ma
anche attualità del messaggio poetico, elemento
questo su cui ha insistito Claudia Zevi, una delle
due curatrici della mostra (l’altra è Meret Meyer,
nipote dell’artista), ricordando che “le avanguardie
del ‘900 hanno avuto il ruolo fondamentale di
cambiare la storia dell’arte, ma con il tempo si
sono concluse. Invece Chagall continua ancora a
parlarci”. Alla base di questo successo, il forte
anelito di libertà espressiva contenuto nella sua
opera, fattore questo colto con estrema preveggenza
dallo storico dell’arte Lionello Venturi che, negli
anni ’50, in pieno periodo informale, vedeva
nell’artista russo “le forme e i colori” che
“daranno ancora gioia all’umanità” quando “molta
della pittura che oggi viene esaltata sarà
dimenticata”.
E infatti ancora oggi
resta intatto il valore simbolico del suo
immaginario, affollato da feste popolari,
rappresentazioni carnevalesche e del teatro ebraico,
adunate circensi e ricordi di antiche fiabe, il
tutto “condito” da un profondo senso religioso,
tanto sentito e sincero da permettere a lui, ebreo
chassidico (una corrente del mondo ebraico che non
approva la riproduzione della figura umana, ndr), di
dipingere una sconvolgente Crocifissione
quale momento di supremo sacrificio di un Gesù ebreo
fino all’ultimo alito di vita. “Chagall – ha
proseguito nel suo ragionamento la Zevi – è stato un
uomo religioso, ebreo, ma aperto a tutte le
confessioni. Per lui dipingere era una esigenza
interiore”. “Ma Chagall era anche russo - ha
aggiunto la curatrice – e in lui conviveva la
cultura ortodossa, e in particolare quella delle
icone, con i loro forti colori e la totale
indifferenza alla ripetitività delle formule. Il suo
messaggio – ha concluso la Zevi - era che tutte le
religioni sono uguali”.
E poi i suoi animali:
cavalli, galli, capre; soprattutto
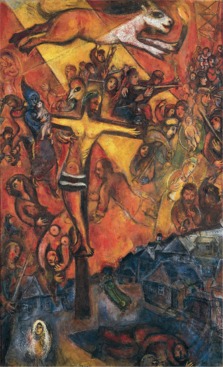 quelle capre “dal
volto semita”, per dirla con Umberto Saba, che con i
loro occhi ampi sembrano dialogare in ogni quadro
con il pittore e l’osservatore. E poi i suoi colori.
Accesi sempre, vivissimi alcune volte, sfumati
altre, ma con dominanti rosse, verdi e blu. Strisce
“impazzite” di rutilanti girandole che attraggono
ipnoticamente l’osservatore fino a “risucchiarlo” in
uno spazio senza tempo in cui ci si può ritrovare
bambini e seduti a tavola con una capra. quelle capre “dal
volto semita”, per dirla con Umberto Saba, che con i
loro occhi ampi sembrano dialogare in ogni quadro
con il pittore e l’osservatore. E poi i suoi colori.
Accesi sempre, vivissimi alcune volte, sfumati
altre, ma con dominanti rosse, verdi e blu. Strisce
“impazzite” di rutilanti girandole che attraggono
ipnoticamente l’osservatore fino a “risucchiarlo” in
uno spazio senza tempo in cui ci si può ritrovare
bambini e seduti a tavola con una capra.
Ecco allora che lungo
il percorso della mostra si ammirano le stampe
popolari, quei lubok così importanti per la
formazione di Chagall, pronti a svelarci il loro
repertorio iconografico. Seguono i piccoli ritratti,
prezioso prestito dei suoi attuali eredi, che ci
svelano particolari della sua famiglia: la madre
mentre fa il pane, poi i suoi otto fratelli, tutti
vittime dei terribili pogrom che colpirono la
comunità ebraica nell’Urss di Stalin, mentre il
pittore faceva la spola tra Parigi, Berlino e gli
Stati Uniti. Opere in cui si vedono le stradine di
Vitebsk, il suo paese natale (oggi in Bielorussia),
ritratti di un mondo perduto in cui si parlava e si
pensava in yiddish, la cultura che Moni Ovadia,
scelto come narratore del video che introduce alla
mostra, da anni ripropone nei suoi spettacoli. Scene
queste in cui il dolore, legato alla gioia di
vivere, dà origine a un modo di raccontare la realtà
che caratterizzerà tutta la pittura di Chagall.
Simbolo di questo travaglio, l’angoscia contenuta ne
L’Angelo caduto, uno dei suoi capolavori,
iniziato nel ’23 e terminato soltanto nel ‘47. O
l’immagine dell’Ebreo Rosso, il cui sguardo
torvo, accentuato dall’occhio chiuso e dalle pieghe
del volto, diviene il simbolo del capro espiatorio
che il popolo eletto ha spesso rappresentato nel
corso della storia.
Ma al Vittoriano sono
evidenziati anche i diversi periodi della vicenda
biografica di Chagall. Dopo le tele ispirate alla
sua cittadina di origine (Nudo rosso e La
morte), alcune opere, tra cui spicca
Autoritratto al cavalletto, testimoniano
l’impatto che il cubismo di Picasso ebbe sulla sua
pittura nel corso del primo soggiorno a Parigi (1910
– 1914). Perché é nel “ventre di Parigi” che Chagall
si lascia catturare dal cubismo, sempre però
filtrandolo attraverso la sua poetica visionaria. Ma
Parigi vuol dire per Chagall anche un ripensamento
sulle sue origini. Emergono così per la prima volta
quelle immagini, tratte dalla cultura popolare
russa, che caratterizzeranno poi molta della sua
produzione: i fiori, gli artisti di strada, gli
animali-simbolo.
Dopo quattro anni di
Francia, però, la nostalgia per la sua terra lo
riconduce in patria. Doveva essere un breve ritorno,
ma lì lo coglie la guerra. Nel ‘17 vive così in
prima persona la Rivoluzione Russa, appassionandosi
agli eventi fino a ricoprire anche delle cariche
istituzionali a Vitebsk.
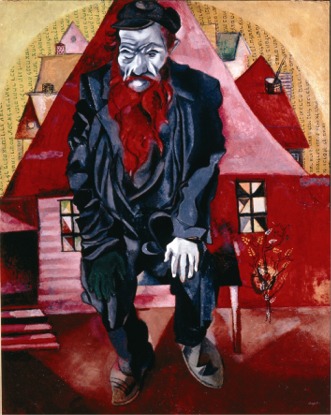 L’idillio dura poco però,
presto azzerato dalla necessità rivoluzionaria di un
realismo che non poteva concedersi “svolazzi”
fantastici sui tetti di una città. Entra così in
conflitto con il Suprematismo di Malevic e ben
presto viene allontanato da ogni carica pubblica. In
questi stessi e intensi anni (1914 – 1923) si corona
il suo sogno d’amore con Bella Rosenfeld, la musa
del Ciclo di Vitebsk, che la mostra ricorda
con Il Matrimonio, Sulla città, La
Passeggiata e Lo specchio. L’idillio dura poco però,
presto azzerato dalla necessità rivoluzionaria di un
realismo che non poteva concedersi “svolazzi”
fantastici sui tetti di una città. Entra così in
conflitto con il Suprematismo di Malevic e ben
presto viene allontanato da ogni carica pubblica. In
questi stessi e intensi anni (1914 – 1923) si corona
il suo sogno d’amore con Bella Rosenfeld, la musa
del Ciclo di Vitebsk, che la mostra ricorda
con Il Matrimonio, Sulla città, La
Passeggiata e Lo specchio.
Dal ’23 è di nuovo a
Parigi, artista ormai conosciuto, pronto a dedicarsi
a una nuova attività che si va ad aggiungere alla
pittura: quella di illustratore. Fu il grande
mercante d’arte parigino Vollard ad avere la giusta
intuizione: commissionare a Chagall le illustrazioni
de “Le anime morte” di Gogol, de “Le favole” di La
Fontaine e della “Bibbia”. Negli anni ’30 una nuova
e ulteriore evoluzione: iniziano quei viaggi tra
Palestina, Italia, Svizzera e Polonia che
stimoleranno la sua idea dell’ebreo errante in
preghiera.
Ma sull’Europa inizia
ad aleggiare lo spettro del nazismo e delle atroci
persecuzioni che porteranno all’Olocausto. L’ebreo
Chagall nel ’40 è costretto all’esilio negli Stati
Uniti da cui tornerà soltanto otto anni dopo, a
guerra abbondantemente finita per stabilirsi, questa
volta in maniera definitiva, in Francia, a Vence. Di
questo periodo sono le sue esperienze in ceramica e
scultura, come pure la decorazione del soffitto
dell’Opera di Parigi, di cui in mostra è esposto il
bozzetto autografo. Poi, i temi religiosi, che
divengono, con il passare degli anni, sempre più
centrali nella vita di Chagall che passa dalla
tradizione iconografica ebraica a quella biblica e
cristiana senza alcuna esitazione. Il frutto potente
e finale di un’ispirazione sempre viva, degna
conclusione di un percorso che mai nulla aveva
concesso alla convenzione e all’ipocrisia, è il
Cristo, vestito dei tradizionali abiti ebraici, che
Chagall dipinge sulla Croce. In questo grande
trittico intitolato Resistenza, Resurrezione,
Liberazione, Chagall non fa che confermare, se
mai ce ne fosse stato bisogno, la sua natura
profonda, permeata da uno spiritualismo che lo aveva
spinto a sentirsi e definirsi “un mistico. Io non
vado in chiesa o in sinagoga. Per me lavorare è
pregare”.
*Fino al 1 luglio
2007. Orario: dal lunedì al giovedì dalle
9.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato fino alle
23.30, la domenica fino alle 20.30. Ingresso:
intero 10 euro, ridotto 7,50 euro. Info allo
066780664.
|
|





